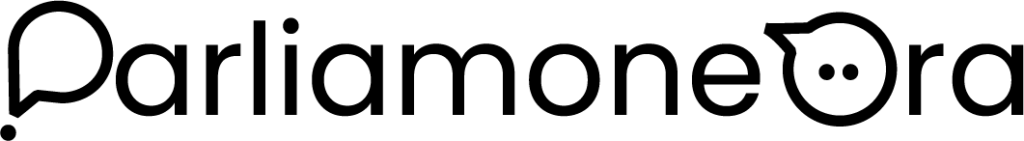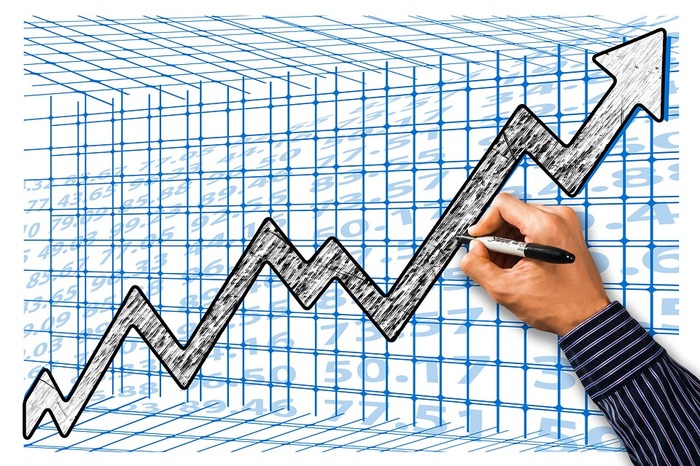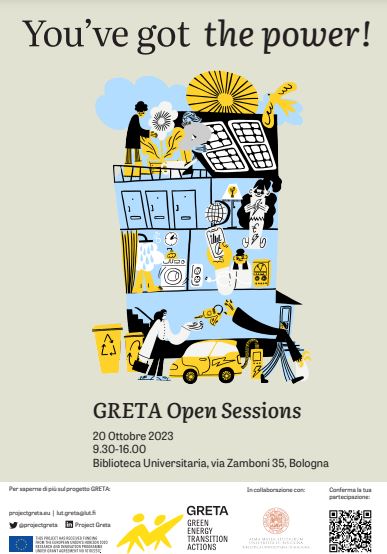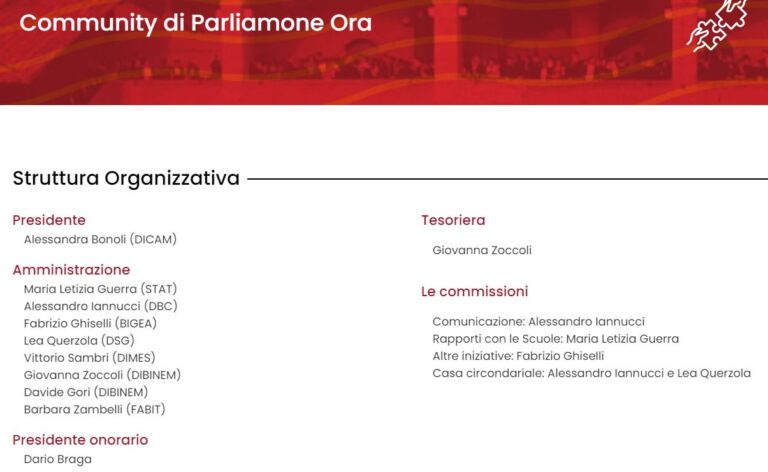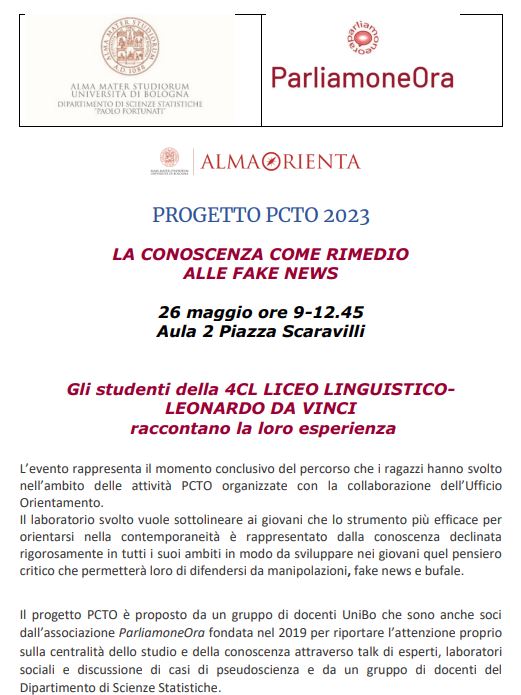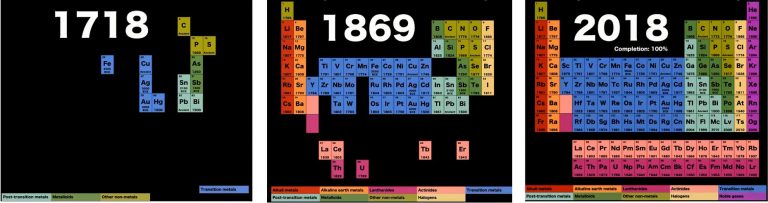Contributo di Alberto De Bernardi
Stato e destino
La più ricorrente delle similitudini storiche diffuse nei media e nel dibattito pubblico e quella che paragona il Covid-19 a una guerra. Le parole più ricorrenti sono infatti tratte dal lessico militare – trincea, prima linea, campo di battaglia, armi ecc – che evocano una lotta senza esclusione di colpi: una guerra, appunto lascia sul terreno morti e feriti. Ma le guerre, soprattutto quelle mondiali, che hanno caratterizzato il XX secolo, non sono solo eventi militari, ma fenomeni storici molto più complessi che comportano una trasformazione profonda del rapporto tra individui, società e nazione. Per essere combattuta una “grande guerra” deve diventare “un destino comune” al quale vanno subordinati gli interessi individuali e la possibilità di poter disporre liberamente della propria esistenza – cioè perseguire il proprio destino individuale – non solo per quelli che vengono “mandati al fronte” come soldati, ma anche per quelli che continuano a svolgere la loro vita civile. Anche chi non combatte e vive nelle retrovie è chiamato a una serie di obblighi: nelle guerre “vere” il razionamento del cibo, il coprifuoco, i divieti di spostamento, il silenzio; in questa “guerra al virus” l’obbligo di stare a casa e di portare la mascherina, il distanziamento sociale, le quarantene.
La creazione di un destino comune chiama in causa lo stato come effettivo promotore, amministratore e controllore dei sacrifici imposti da quella scelta, che non sono solo materiali, ma che molto rapidamente si dilatano ad altre sfere della vita collettiva e che chiamano in causa la libertà di pensiero e le scelte politiche: nelle guerre vere contestare le scelte statali fino a negarne la loro legittimità, era assimilato al tradimento, all’intendenza con il nemico e quindi punibile persino con la morte, con cui si è combinata una progressiva asfissia del parlamento trasformato in una macchina acritica utile solo ad approvare le scelte del governo., perché anche la dialettica tra i partiti era considerata un pericolo per l’unità “organica” della nazione.
Ma il perseguimento del destino comune cozza immediatamente con la democrazia, che è lo spazio politico dove si alimenta il pluralismo delle idee e il conflitto tra differenti destini collettivi: le guerre hanno sempre chiuso i parlamenti, impedito le elezioni, soppresso molte libertà civili.
Nella lotta alla pandemia questo non accade in termini così radicali, ma indubbiamente si assiste a una marginalizzazione del parlamento e a un ottundimento del ruolo dell’opposizione e del dibattito parlamentare: i pieni poteri concessi ai presidenti dell’Ungheria e della Slovenia costituiscono un esempio, lampane, anche se estremo, di questa tendenza. Parallelamente si assiste al diffondersi nell’opinione pubblica un atteggiamento di condanna e di discredito nei confronti di chi mette in dubbio le scelte governative e si permette di criticare l’operato della macchina organizzativa disposta dallo stato per fronteggiare la pandemia.
Guerra e democrazia
Come scrisse nel 1917 una famoso sociologo tedesco, Johann Plenge, la Prima guerra mondiale aveva messo in soffitta le parole d’ordine della Rivoluzione francese – libertà, fraternità, eguaglianza – sostituendole con la triade, “dovere, ordine, giustizia”. Seppur non nei termini che si verificarono un secolo fa per ampiezza e profondità anche oggi nella lotta al Covid-19 riemerge un ripiegamento verso la delegittimazione del pensiero critico, sia che invochi la centralità del parlamento, sia che revochi in dubbio la strategia seguita per combattere l’epidemia o metta in guardia dalla necessità di evitare che il “tutti a casa” diventi un messaggio securitario. In sostanza come nella guerra vera anche in questa “metaforica” si ripresenta quella tendenza alla diffusione dello “spirito gregario” – cioè quella “sete di obbedienza” tra le masse di fronte all’irruzione dell’imprevisto – su cui Freud ha scritto pagine memorabili proprio dopo la guerra del ’14 -’18 (Psicologia delle masse e analisi dell’io, 1921) – che fa sembrare Conte l’erede di Churchill e fa perdere di vista la tutela dei principi dello stato di diritto e della democrazia liberale.
L’economia di guerra

Ma dove la centralità dello stato si è affermata con maggior forza durante le guerre è stato nel campo dell’economia, tal punto che è stata elaborata l’espressione “economia di guerra”. Lo stato, attraverso enti costruiti ad hoc, si mette al centro del processo produttivo facendosi promotore dello sviluppo delle forze produttive, attraverso la crescita abnorme della domanda pubblica, centralizzando così il mercato e annullando al concorrenza: enormi investimenti pubblici stimolarono lo sviluppo industriale e la ricerca tecnologica per la produzione bellica affidata al sistema delle imprese private, obbligate a produrre per conto dello stato, in un quadro di rigoroso protezionismo. Molti stati, tra cui l’Italia, divennero paesi industriali proprio per il balzo in avanti produttivo che lo “stato imprenditore” impose all’economia nazionale sacrificando tutto quello che non era immediatamente utile all’ “obbiettivo supremo” della guerra.
In questo campo le similitudini tra la pandemia e la guerra si complicano: la guerra novecentesca, pur all’interno di un quadro distruttivo di uomini e cose, è stata uno straordinario fattore di sviluppo industriale, mentre l’attuale pandemia come quelle che l’hanno preceduta, ci configura come un blocco forzato delle attività economica, perché la quarantena di massa di miliardi di persone, chiuse nelle proprie case, paralizza l’economia. Ciò che accomuna i due fenomeni è da un lato il loro carattere eccezionale e abnorme, dall’altro che è lo stesso ente promotore, lo stato, a decretare in un caso un aumento forsennato della produzione e la trasformazione di donne e di uomini in operai della guerra, e nell’altro il blocco totale del lavoro, la chiusura delle aziende e la dissoluzione delle capacità produttive.
Guerre e modelli di sviluppo
Ma l’economia di guerra non è stata solo un grande sforzo produttivo, perché la realizzazione del processo di centralizzazione statale dell’intero sistema economico ha comportato una profonda alterazione del capitalismo di matrice liberale, fondato sulla concorrenza e sull’auto-organizzazione degli interessi contrapposti, perché ha modificato radicalmente il rapporto tra stato e mercato, creando una sorta di capitalismo senza mercato interamente dipendente dallo stato, divenuto supremo organizzatore della produzione, ma anche rigido controllore del conflitto sociale e della libera dialettica degli interessi ritenuti fenomeni dissipatori di risorse e di energie economiche. La guerra di fatto aveva generato un modello economico statalista e corporativo che ebbe un lungo itinerario nel XX secolo.
L’eredità della “nazione in armi”, dunque, non fu solo una economia interamente piegata alle logiche del conflitto, la cui riconversione ad una economia di pace fu lunga e dolorosa, ma anche un modello di sviluppo statalista e monopolista nei confronti del quale nei due dopoguerra – quello degli anni 19-21 e quello degli anni 45-48 – si generarono esiti molti diversi.
Negli anni ’20 quel modello venne proposto da economisti e forze politiche come la chiave di volta per uscire dall’economia liberale e dare vista a una nuova proposta corporativista – un intreccio di «produttivismo» e di «disciplina sociale» – che trovò nel nazionalismo prima e poi nel fascismo i suoi più convinti sostenitori. In nome degli «interessi nazionali», lo stato infatti si assumeva l’onere di costruire – e di imporre, se necessario – l’«ordine» nel quale potessero dispiegarsi le forze produttive, favorendo non solo la combinazione degli interessi, ma anche i processi di riorganizzazione di modernizzazione del sistema produttivo; il mercato, liberato da conflitti e concorrenza, poteva ritornare a funzionare come spazio dell’iniziativa privata, sottoposta però anch’essa ai dettami dell’interesse della nazione in mano al decisore politico. Dietro i pugnali e i moschetti degli squadristi, tra il 1921 e il 1922, si delineò questo progetto politico che ebbe un notevole potere di attrazione nei confronti delle classi dirigenti imprenditoriali e delle classi medie e che dilago a macchia d’olio nell’Europa tra le due guerre.
Nel secondo dopoguerra la costruzione dell’egemonia americana nell’Occidente significò invece il rifiuto di quel modello che era diventato componente essenziale dei fascismi, e il ritorno al libero mercato e all’iniziativa privata, ma in un contesto nel quale lo stato, attraverso il welfare e la redistribuzione dei redditi che esso comportava, rimaneva al centro dei processi di organizzazione e di riproduzione sociale. Inoltre in alcuni paesi, tra cui l’Italia, i lasciti dello “stato imprenditore” entrarono prepotentemente nella definizione del modello di sviluppo che si impose negli anni del miracolo economico, con il persistente ruolo di indirizzo di alcuni enti – tra cui l’IRI – che erano una potente eredità del fascismo,
Economia di guerra e economia di pandemia

Dietro l’espressione “economia di guerra” si nascondono dunque fenomeni molteplici che attengono essenzialmente al rapporto tra stato e mercato che la guerra altera in maniera significativa. E possibile rintracciare la stessa alterazione nel caso del Coronavirus che giustificherebbe la comparazione tra guerra e pandemia? Abbiamo già visto come questi due fenomeni si comportino in maniera opposta in rapporto allo sviluppo delle forze produttive, ma come emerge dal quello che sta accadendo in questi giorni in tutto il mondo, la pandemia impone allo stato il sostegno massiccio delle economie colpite dalle politiche di quarantena messe in atto per fermare il contagio. Se con la guerra lo stato promuoveva una crescita forsennata delle capacità produttive per poi distruggere bombe e cannoni nei combattimenti, con la pandemia lo stato deve sostenere le imprese, alle quali chiede di bloccare la produzione, e la forza lavoro a cui impone di non lavorare. Ma è evidente che questo processo trasforma lo stato in effettivo organizzatore del sistema economico sostituendosi alle autonome dinamiche del mercato. E come nelle guerre questo intervento si trasforma in debito pubblico, cioè accollando alle future generazioni i costi di questa catastrofe: sia che essi siano buoni del tesoro nazionali, come quelli che tutti gli stati emisero per fare fronte alle spese di guerra, durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, o che siano eurobond o interventi della BCE a sostegno del sistema bancario, non cambia la loro natura di debiti che lo stato contrae per fare fronte all’emergenza.
Dalla pandemia si uscirà, dunque, con più debito pubblico, come accadde dopo le due guerre mondiali, e con un prepotente ritorno dello stato nell’economia, abbandonando i rigori antistatalisti del neoliberismo.
La risorsa europea
Ma cose emerge dall’esperienza bellica l’apparato statale messo in campo per reggere l’impatto dell’evento straordinario ebbe una evoluzione ben diversa nei due dopoguerra: nel primo caso quell’apparato fu messo al servizio di una progetto politico autoritario di matrice panstatalista, che assunse la guerra come modello di ridefinizione dell’identità collettiva; nel secondo venne sostanzialmente smantellato per ridare spazio all’economia di mercato all’interno della quale si collocò l’intervento pubblico con finalità sociali di stampo egualitario. La prima soluzione dell’alternativa, anche se nello scacchiere internazionale non esistono forze che esplicitamente si rifacciano a modelli corporativisti fa parte comunque della tradizione politica del nazionalismo, anche nella sua attuale variante sovranista, e del populismo, laddove evoca il ritorno dello stato dispensatore di sussidi e nazionalizzatore, che per “salvare la nazione” si sostituisce al mercato. La storia insegna inoltre che questo approccio sta in piedi in un sistema di scambi internazionali dominato dal protezionismo, come negli anni trenta.
La seconda soluzione invece evoca l’europeismo e una società aperta, laddove lo stato nell’emergenza sostiene l’impresa perché ritorni a produrre ricchezza e a dare lavoro e protegge i lavoratori soprattutto attraverso politiche pubbliche che ne favoriscano la reimmissione nel mercato del lavoro: date le dimensioni del cataclisma l’Unione europea si rivela la principale risorsa a disposizione per non precipitare nel vuoto, perché nessuno degli stati europei è in grado di governare la ricostruzione postpandemica da solo e men che meno l’Italia. Era già accaduto nell’immediato secondo dopoguerra: per fare la pace, metter al sicuro il ritorno alla democrazia e uscire dal baratro economico della guerra l’unica ancora di salvezza era l’Europa come avevano previsto quei giovani visionari imprigionati nel carcere di Ventotene.