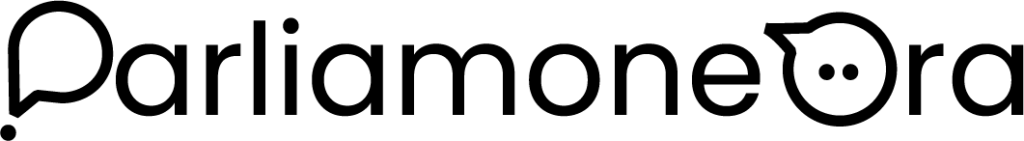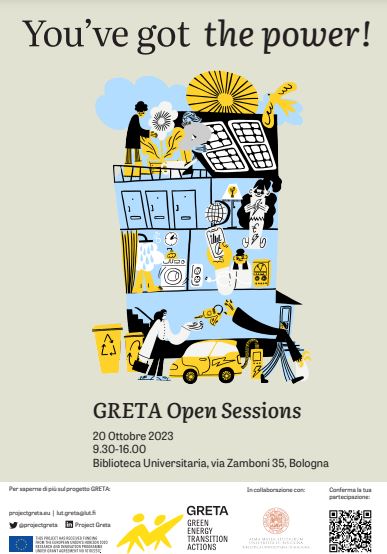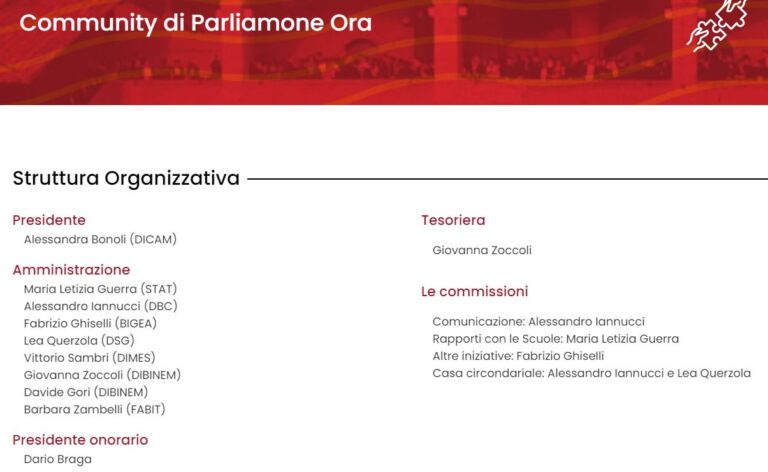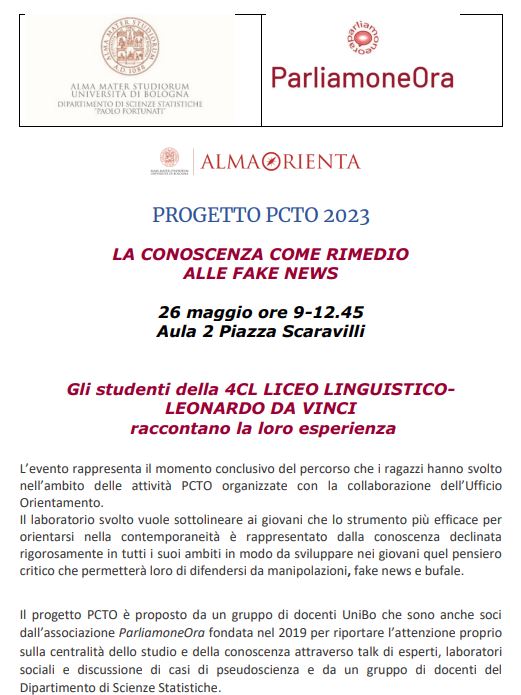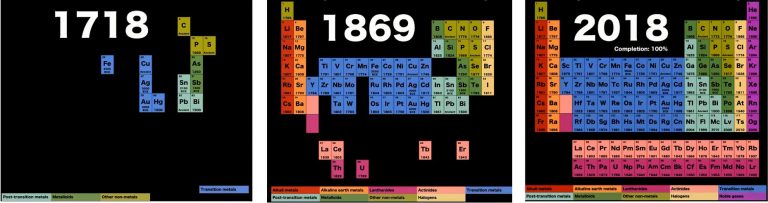“Osservo”, attraverso uno schermo nero e chat, i nostri studenti. Ho un corso di Istituzioni di diritto pubblico, per studenti di primo anno.
Hanno voglia di mettersi in gioco. Ho fatto lezione da remoto subito dopo la prima settimana di sospensione. Ho cercato di stimolarli, incuriosirli. Ho proposto tesine scritte, approfondimenti. Molti hanno reagito attivamente. Ho sperimentato una esercitazione scritta (a partecipazione facoltativa). All’esercitazione ho attribuito un punteggio. Ho detto che avrei valutato che peso dare al risultato, in base alla loro serietà nello svolgimento. Ho precisato che c’era poi possibilità di ridiscuterla oralmente, o con approfondimenti scritti e che mi riservavo di verificare le loro conoscenze con colloqui orali.
La partecipazione alla esercitazione è stata importante. Ho corretto 113 testi. Molti l’hanno fatto per sondare la loro preparazione, altri con maggior convinzione. I quesiti (6 domande aperte) erano particolarmente difficili, perché richiedevo ricerche pratiche (anche utilizzando il web, non potendo impedirglielo!) e riflessioni basate sulle loro conoscenze teoriche. Il risultato è stato: punteggi congrui e testi originali e non copiati. Li ho corretti: dando indicazioni su come migliorarsi e stanno lavorando, approfondendo. Si mettono in gioco.
Ecco, loro sono il presente ed il futuro.

Non credo che si possano rinviare alla fine dell’emergenza progetti per stimolare la crescita. Credo che fin da oggi si deve agire per riprogettare il futuro, su valori che, spesso, abbiamo messo da parte.
È emersa, con forza prorompente, l’esistenza di un “bene di interesse comune” a tutela prioritaria: la salute pubblica. Risolvere la pandemia è prioritario, ma è necessario progettare interventi che vadano oltre l’emergenza: non solo imprescindibili investimenti in sanità, ma anche un intervento globale sull‘ambiente ed infrastrutture, limitando al massimo i fattori lesivi della salute umana. Ripensiamo alle grandi opere, alle infrastrutture: ci vuole il coraggio di abbandonare progetti obsoleti, antichi che non tengono conto dell’impatto sull’ambiente, sulla salute, progetti che procedono il loro iter su VIA superficiali, senza VIS e senza VAS.
La cultura come bene di interesse comune ha indotto ad offrire prodotti on line, a trovare una continuità nel servizio di istruzione. È stato scelto di terminare l’anno scolastico, mediante apprendimento a distanza.
Si potevano fare altre scelte. Fermarsi, fare ripetere l’anno a tutti e posticipare il momento di accesso alla scuola primaria, inserendo un ultimo anno di scuola dell’infanzia obbligatorio e di passaggio. Forse soluzione poco praticabile, non fosse altro per la mancanza di licenziati e diplomati per l’accesso al lavoro ed alla formazione superiore. Si poteva pensare di riprendere la scuola in aula appena possibile e proseguire fino a fine luglio. Ciò avrebbe forse, favorito anche le famiglie e coloro che dovranno fare innumerevoli sforzi per riprendersi; ci avrebbe allineato al tempo scuola in Europa. Anche questa soluzione, forse in Italia è politicamente poco condivisa. Si poteva pensare di fermarsi al programma del primo quadrimestre e modificare i contenuti dei programmi scolastici. Proporre, contestualmente, attività intese ad acquisire competenze.
Si è scelto di proseguire. Si sono “rimboccati” tutti le maniche, prima i dirigenti e gli insegnanti, poi i ragazzi e le famiglie.
Ci si è scontrati con la realtà.
Sono tutti sotto pressione. Si assiste alla corsa all’informatizzazione. I mezzi non sono adeguati, manca la formazione, soprattutto nell’apprendimento a distanza. Progressivamente viene a mancare il significato della comunità scolastica, seppure già ci siano alcune iniziative intese a ricostruire la comunità.
La scuola, tuttavia, oggi è sempre più esclusiva, a vantaggio di chi ha possibilità economiche; esclude i ragazzi che vivono in famiglie che ora devono pensare a sopravvivere: ed in Italia sono tante, non solo nel sud. L’insegnamento scolastico contraddice le politiche di inclusione, comunque già deboli in ogni settore (disabili, stranieri, ma anche ragazzi con capacità superiori). È insufficiente perché non può, oggettivamente, trasmettere le conosce adeguate. Espone all’ignoranza. Il diritto all’istruzione ed allo studio, nella nostra carta costituzionale, deve essere non solo formale, ma sostanziale.
Sono già stati disposti investimenti per acquisto di mezzi. Manca qualcosa però: in assenza di una formazione di base, potrebbe pensarsi alla figura dell’educatore in generale ed oggi, in particolare, di educatori digitali scuola, per gli alunni ma anche per gli insegnanti che ne avvertano la necessità. Altresì, potrebbe essere l’occasione per l’introduzione di figure quali i pedagogisti, che medino tra scuola e famiglia. Fin da oggi, diventa necessario ripensare ad una scuola della inclusione e della partecipazione.

In questo momento di attesa, si deve, altresì, pensare a promuovere lo sviluppo economico perché non muoiano le PMI. Nella carta costituzionale è stato introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale, il codice degli appalti ha dedicato un titolo alla Public-Private Partnership, ma le collaborazioni, spesso sono rallentante. L’amministrazione è scettica, il privato teme, difficili sono i finanziamenti e l’accollo del rischio.
Su tutto questo, aleggiano – dall’alto – i vincoli di bilancio. La situazione di emergenza sanitaria potrà legittimare scostamenti dal raggiungimento dell’OMT (art. 6 l. n. 243/12), ma è necessario fin da ora trovare le modalità per ritornare verso una politica finanziaria sana e sostenibile. Questo non tanto per il timore della “tirata d’orecchi” dell’Europa, né per litigi, legati a manovrine al limite. Questo in ragione di quanto scrive la corte costituzionale: l’equilibrio di bilancio è un bene (di interesse) comune, per oggi e per generazioni future, nell’ottica di un impegno solidaristico concreto.