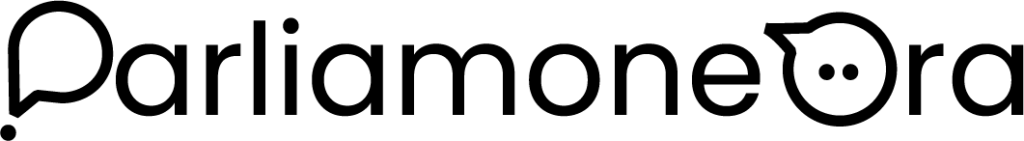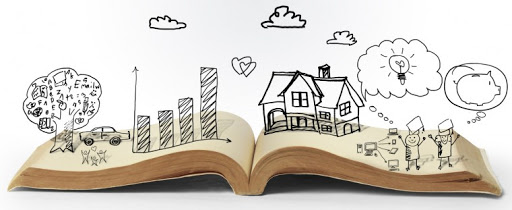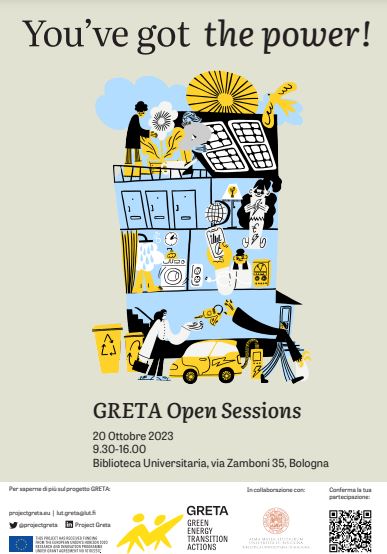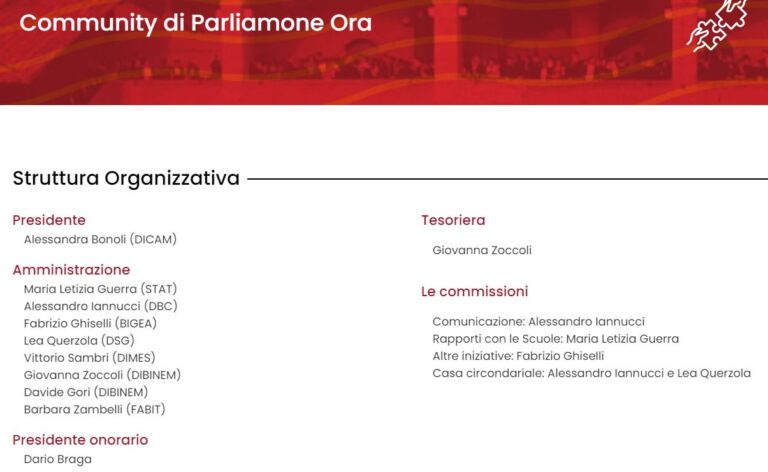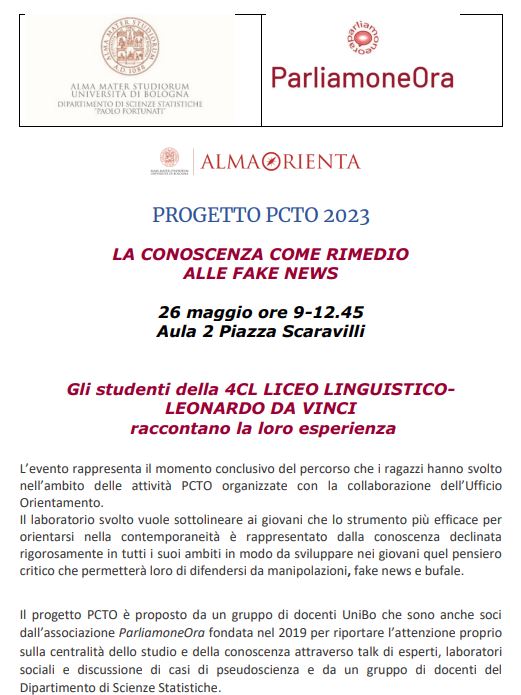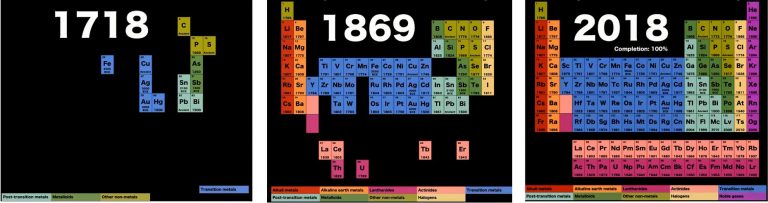Durante la pausa natalizia ho letto il Sillabario di genetica per principianti di Guido Barbujani (Firenze: Giunti Editore, 2019). Nel capitolo sugli OGM vi è un esempio in grado di porre un profondo dilemma morale nel lettore, che prende vita come tale solo se si capisce almeno un po’ di che cosa si stia parlando. Il golden rice è una varietà di riso OGM ricca di betacarotene, che riduce i danni da mancanza di vitamina A e per questo è utile ad evitare la morte e la cecità nei bambini nelle zone più povere del Sud-est asiatico, dove si coltiva riso bianco e lo si consuma decorticato.
Il golden rice, risultato della ricerca scientifica, è da anni al centro di diatribe politiche, economiche e sociali: è contro natura, si dice di lui, perché costruito in laboratorio; è una nuova forma di colonialismo economico da parte delle multinazionali; è uno strumento per ridurre la biodiversità e creare un impoverimento complessivo degli agricoltori di quelle zone, tesi sostenuta in modo appassionato anche da Vandana Shiva, certo non l’ultima arrivata sulla scena internazionale.
Barbujani prima si premura di fare in modo che il lettore abbia un quadro del problema, seppure non esaustivo, ma sufficiente perché, leggendo, si costruisca il dilemma: non coltivare il golden rice per tutti i motivi di cui si è detto oppure coltivarlo per migliorare la salute e la qualità della vita di tanti bambini? Se viene data una risposta in termini di opinioni (secondo me si deve coltivare, oppure non si deve coltivare), lo sforzo del sillabario non sarà servito a nulla, ma se qualcuno, dopo aver letto, cercherà altri argomenti per capire meglio quale soluzione adottare, allora questa conoscenza di base sarà servita come starter per avviare un percorso di curiosità, di interesse e di approfondimento.
Poi a gennaio sono arrivate le prime notizie sul COVID-19 ed in febbraio è uscito il nuovo instant book di Roberto Burioni e Pier Luigi Lopalco, dal titolo Virus. La grande sfida. Il secondo capitolo si intitola” Contatto e contagio” e racconta lo sforzo di sopravvivenza di Rabdo che, passato da una volpe morente al cane Whiskey nell’attimo di un disperato ultimo morso, spinge il cane a mordere il suo padroncino ed a consentire a Rabdo di trovare un nuovo ospite temporaneo. Rabdo, il virus della rabbia, sembra un Rambo infinitesimamente piccolo ma altrettanto determinato. E poi si prosegue con il racconto di epidemie, di ratti e dei loro pidocchi, che sulle navi riescono a decimare tutti i marinai con drammatiche epidemie di peste (e qui consiglio di rivedere Bandiera gialla di Elia Kazan, 1950, uno dei miei incubi di bambina, dopo averlo visto in televisione!).
Ma non è finita: i virus sono praticamente degli zombie, perché se trovano il loro ospite possono essere paragonati ad esseri viventi, come le mucche (quindi sono vivi), ma se l’ospite non c’è restano solo piccolissime particella di materia inanimata, inanimata come una bistecca (quindi un non vivi) e il culmine si tocca quando, per spiegare in modo ancora più vivido il machiavellismo dei virus, vengono chiamati in causa i dinosauri: un virus di questi bestioni (p. 63):
rimasto infettivo nell’ambiente del Giurassico fino ad oggi, non è un virus, ma qualcosa di completamente inanimato perchè i dinosauri sono estinti,…ma se riapparissero i dinosauri, come è accaduto in qualche film di fantascienza, tornerebbe magicamente virus
Un vero Jurassic park, altro che lo zoo safari dietro casa!
Appassionante, senza dubbio, ma oltre a questo cosa accomuna i due volumi? Di certo lo scopo degli autori è quello di divulgare le conoscenze scientifiche, offrendo al lettore le informazioni che gli permettono di prendere posizione, come nel caso degli OGM, o di decidere, come nel caso delle epidemie, quali siano i comportamenti corretti da seguire per evitare che il virus si diffonda, perché più carte del mazzo si possiedono e più è facile comprendere anche le ragioni di scelte di salute pubblica che altri prendono per noi.
Però, quello che veramente hanno in comune i due volumi, è una divulgazione che ha imboccato la strada della narrazione e del racconto, senza il timore di scegliere esempi non convenzionali, se questi ultimi sono in grado di suggerire collegamenti tra i risultati della ricerca scientifica e la nostra esperienza quotidiana, dove tutto ciò che facciamo è un compito reale, con un significato diretto nelle nostre vite. La comunità scientifica potrebbe riflettere sul fatto che si può ridere delle scoperte scientifiche (su questo consiglio la lettura, o la rilettura, di Lascia stare i santi, sempre di Barbujani) e fare lo sforzo di abbandonare, passo dopo passo, la sicurezza che ci viene dall’indossare l’abito da cerimonia dei numeri che parlano al posto nostro, dell’aderenza ortodossa alle teorie ed ai metodi, dalla pretesa che siano gli altri ad avvicinarsi a noi, consegnando la loro fiducia nelle nostre mani come se fosse un assegno in bianco.
Proviamo invece a raccontare “buone storie” nell’ambito delle nostre discipline e sono sicura che il pubblico, lentamente, ci darà fiducia e ci chiederà di raccontare ancora.